Introduzione
Capire, sostenere, accompagnare. Sono queste le tre parole che guidano il lavoro quotidiano di Marco Ameglio, operatore con oltre vent’anni di esperienza nel campo delle dipendenze. Ha lavorato in comunità terapeutiche residenziali e post-residenziali, accompagnando centinaia di persone nel difficile percorso di uscita dall’abuso di sostanze. È oggi responsabile di percorsi di mantenimento e gruppi di reinserimento per ex-pazienti, dove promuove un approccio basato sulla continuità, sulla presenza e sulla centralità delle famiglie nella cura.
In questa intervista, raccolta nell’ambito delle attività editoriali della Fondazione Laura e Alberto Genovese, Marco ci offre uno sguardo profondo, umano e realistico su cosa significa affrontare un percorso di cura, dentro e fuori la comunità. Le sue parole, frutto non solo di competenze professionali ma anche di una lunga esperienza a contatto con la fragilità, rappresentano una guida preziosa per chi si trova ad affrontare situazioni complesse legate alla dipendenza.
L’obiettivo di questo articolo non è solo informare, ma dare voce a un punto di vista che spesso resta invisibile: quello delle famiglie. Perché quando una persona cade nella spirale della dipendenza, non ne soffre mai da sola. A essere coinvolti – spesso travolti – sono genitori, fratelli, partner, amici. E spesso, chi sta vicino si sente impotente, confuso, privo di strumenti.
Questo contenuto nasce con uno scopo preciso: offrire orientamento, comprensione e speranza alle famiglie che cercano risposte. È un piccolo pezzo di quella “rete di protezione” di cui Marco parla spesso, e che rappresenta il cuore del lavoro della Fondazione: una rete fatta di ascolto, di formazione, di relazioni autentiche e di accompagnamento concreto.
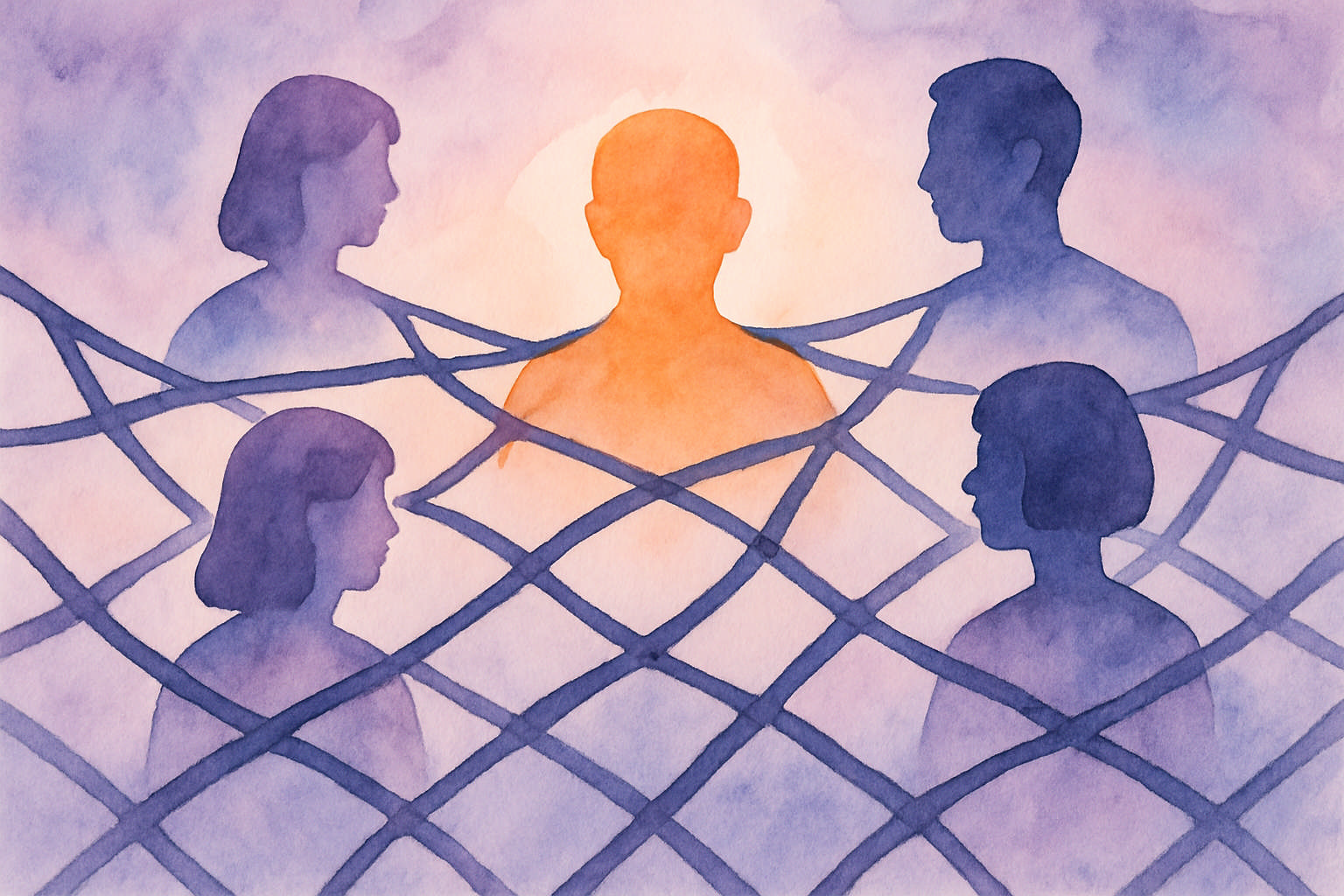
Attraverso il racconto diretto di Marco vogliamo ricordare che la dipendenza è una malattia, non una colpa e che, come ogni malattia, ha bisogno di cura.
Il Percorso di Cura: Comunità, ma non solo
Quando si parla di comunità terapeutiche, l’immaginario collettivo spesso oscilla tra due estremi: da un lato la speranza della guarigione, dall’altro la paura di un luogo chiuso, lontano dalla vita reale. Ma com’è davvero l’esperienza di una persona che entra in comunità per affrontare una dipendenza?
“All’inizio è uno shock,” racconta Marco Ameglio. “Molti la vivono come una punizione, come una prigione. ‘Cosa ho fatto per meritarmi questo?’ è una domanda che sento spesso. Eppure, con il tempo, la percezione cambia.” La comunità diventa gradualmente un luogo protetto, un rifugio, un’opportunità concreta per riprendere in mano la propria vita.

Ma perché questo cambiamento avvenga, è necessario un elemento fondamentale: il tempo.
Il percorso terapeutico non è una corsa contro il tempo, non esistono tempi standard validi per tutti. “Ci sono persone che restano sei mesi, altre che hanno bisogno di un anno o più. Ma non conta quanto tempo resti, conta quello che riesci a fare dentro quel tempo. Conta la trasformazione che riesci ad attivare.”
Uno dei momenti più delicati è proprio quello del “dopo”, quando termina il periodo residenziale e la persona deve rientrare nella vita quotidiana. “Fuori non ci sono le regole della comunità, né il contenimento emotivo che offre. È lì che spesso si gioca la vera partita,” sottolinea Marco.
Per questo esistono percorsi semi-residenziali o di reinserimento graduale, come gli appartamenti protetti, dove le persone iniziano a gestire le prime responsabilità: cercare lavoro, costruire relazioni sane, imparare a riconoscere le emozioni e affrontarle senza sostanze.
La comunità, quindi, non è un punto di arrivo, ma un passaggio fondamentale in un processo molto più ampio e articolato.
E se ben strutturato, questo processo non si chiude con la dimissione: continua nei gruppi di mantenimento, nel lavoro con la famiglia, nella costruzione quotidiana di una nuova normalità.
Sostanze e ambiente: le trappole invisibili

Quando si pensa alla dipendenza, l’immaginario comune tende a classificare le sostanze in “leggere” e “pesanti”, come se il pericolo dipendesse unicamente dalla chimica. Marco Ameglio smonta subito questo mito:
“Le sostanze sono tutte uguali. Tutte possono generare una dipendenza. Non è la sostanza in sé, ma il legame che la persona costruisce con essa.”

Questo significa che per alcuni può essere devastante la cocaina, per altri l’eroina, per altri ancora… la cannabis o l’alcol. E proprio l’alcol, secondo Marco, è la sostanza più insidiosa. Non per i suoi effetti farmacologici, ma per un motivo molto più profondo: l’ambiente che la circonda.
“L’alcol è ovunque. È accettato, è proposto, è persino celebrato. Per molti ragazzi è difficile persino immaginare una socialità senza bere. E questo rende tutto più pericoloso,” spiega. L’alcol, infatti, agisce come un disinibitore: spegne le emozioni, attenua la vergogna, la paura, il senso di fallimento. Ma proprio per questo può diventare una porta d’accesso alla ricaduta, anche dopo lunghi percorsi terapeutici.
La questione non riguarda solo le sostanze classiche. Negli ultimi anni, fenomeni come il “chemsex” (uso di sostanze stimolanti in contesti sessuali, soprattutto tra giovani uomini) e le droghe da rave hanno aggiunto nuovi elementi di complessità. “Non si tratta più solo dell’effetto della sostanza,” dice Marco, “ma di esperienze costruite attorno a certe sostanze. Dove il desiderio, il corpo, la mente, vengono portati al limite.”
Anche la ludopatia, spesso considerata separata dal discorso della tossicodipendenza, rientra nella stessa logica: dipendenza da comportamento, disinibizione, perdita di controllo, impatto sulle emozioni. “Chi gioca d’azzardo, spesso beve. Chi beve, spesso cerca altro. Sono percorsi che si intrecciano. E sempre, alla base, c’è una fragilità emotiva profonda.”
È per questo che Marco invita a guardare oltre la sostanza. La vera cura, infatti, non passa solo dalla disintossicazione fisica, ma dalla ricostruzione emotiva, relazionale e identitaria. Perché è lì che le dipendenze nascono: nel vuoto, nell’insoddisfazione, nel bisogno di anestetizzare il dolore.
Il ruolo della famiglia: alleata, non spettatrice

In ogni percorso di cura dalla dipendenza, c’è un protagonista spesso invisibile ma essenziale: la famiglia. Genitori, fratelli, partner o amici stretti: chi vive accanto a una persona che soffre di dipendenza gioca un ruolo cruciale. Ma perché questo ruolo sia realmente d’aiuto, è necessario uscire dalla logica del salvataggio e entrare in quella dell’alleanza terapeutica.
“Una famiglia può essere la più grande risorsa, oppure un ostacolo. Tutto dipende da quanto riesce a stare nel percorso, senza volerlo controllare, senza sostituirsi,” spiega Marco Ameglio. Il concetto centrale è semplice, ma tutt’altro che facile da mettere in pratica: la famiglia non può curare, ma può sostenere chi si sta curando.
Spesso, infatti, chi sta accanto a una persona dipendente vive in uno stato di allarme costante: controlla, teme, anticipa, copre. E nel tentativo di proteggere, finisce per alimentare inconsapevolmente la dipendenza. È per questo che molte comunità, come quella in cui opera Marco, prevedono percorsi paralleli per le famiglie, con incontri dedicati, momenti di formazione e supporto psicologico.
Uno dei primi passi fondamentali è “chiudere i rubinetti” economici: una misura difficile, dolorosa, ma necessaria. “Non si può aiutare qualcuno a liberarsi da una dipendenza continuando a fornirgli i mezzi per alimentarla,” sottolinea Marco. “Alcuni genitori arrivano persino a comprare la sostanza pur di evitare che il figlio si metta in pericolo. Ma questo non è aiuto, è complicità involontaria.”
In questi casi, la famiglia deve essere accompagnata passo dopo passo, aiutata a riconoscere i propri meccanismi disfunzionali, a riconquistare un ruolo educativo, non punitivo, ma fermo. “Servono regole, ma anche affetto. È quello che chiamiamo ‘amorevole distanza’: io ci sono, ti voglio bene, ma non posso essere il tuo alibi per non curarti.”
Fondamentale, infine, è non rimanere soli. Le famiglie devono sapere che non è una sconfitta chiedere aiuto, anzi: è il primo vero atto di coraggio e responsabilità. È per questo che la Fondazione Laura e Alberto Genovese ha scelto di offrire percorsi di supporto dedicati proprio a loro, per aiutarle a trasformare il dolore in forza, la confusione in consapevolezza, la rabbia in presenza.
Cosa fare quando…
Ogni famiglia che si trova a convivere con la dipendenza di una persona cara si pone, prima o poi, la stessa domanda: “Cosa dobbiamo fare?”. E la risposta, purtroppo, non è mai semplice o immediata. Perché ogni situazione è unica. E ogni percorso di cura è diverso. Ma ci sono alcuni scenari ricorrenti, e Marco Ameglio – con la sua lunga esperienza in comunità terapeutiche – li conosce bene.

…la dipendenza è appena emersa
Quando si scopre per la prima volta che un figlio, un partner o un familiare fa uso di sostanze, l’istinto è agire subito: parlare, cercare soluzioni, insistere perché accetti un aiuto. Ma il primo passo dovrebbe essere un altro: la famiglia deve farsi aiutare.
“Il problema non è solo del ragazzo o della ragazza che si fa. In quel momento, anche la famiglia è in crisi. E ha bisogno di strumenti per capire cosa sta maneggiando,” spiega Marco. Spesso si tende a minimizzare (“è solo un periodo”, “tutti i giovani fumano”), oppure a intervenire con gesti impulsivi. Ma prima di intervenire, bisogna informarsi, farsi guidare, ascoltare.
Le domande giuste da porsi non sono solo “che sostanza usa?”, ma: va a scuola/lavoro? Ha cambiato abitudini? Ha bisogno di soldi spesso? Ha comportamenti nuovi o preoccupanti? Sono questi i segnali che un professionista può aiutare a leggere nel modo corretto.
…la situazione va avanti da tempo e nulla sembra funzionare
Molte famiglie arrivano nei centri come l’ultima spiaggia, dopo anni di tentativi, discussioni, fughe e ricadute. “Sono spesso madri che chiamano con il cuore a pezzi, chiedendo di far entrare il figlio in comunità. Ma la prima domanda che facciamo è: ‘Tuo figlio ci vuole entrare?’ E quasi sempre la risposta è no.”
E allora? “Allora bisogna accettare una verità dura: non possiamo costringere nessuno a curarsi. Ma possiamo prepararci. Possiamo costruire intorno a quella persona un contesto che, quando sarà pronta, la sosterrà davvero.”
In certi casi, serve prendere decisioni difficili: denunciare per proteggerlo, chiudere ogni sostegno economico, prendere le distanze affettive per non distruggere sé stessi. È qui che entra in gioco il concetto di “amorevole distanza”: essere presenti, ma senza essere il bersaglio della rabbia o della dipendenza dell’altro.
…la persona non vuole curarsi
È forse lo scenario più frustrante per una famiglia. Ma, come dice Marco con lucidità: “La dipendenza è una malattia a rischio vita. E chi è dentro non vede il rischio, non sente il pericolo. La famiglia sì, ed è per questo che deve essere guidata da chi ha esperienza.”
Non esistono scorciatoie. Esistono tempi, strategie, e la forza di stare vicini senza farsi risucchiare. La famiglia deve creare le condizioni perché, quando quella persona sarà pronta a chiedere aiuto, sappia dove andare, sappia con chi parlare, sappia di non essere sola.
Se ti riconosci in uno di questi scenari, non aspettare di toccare il fondo. Contattaci. Insieme possiamo costruire un percorso. Anche quando tutto sembra impossibile.
Dopo la comunità: percorsi di mantenimento e rinascita

Una delle illusioni più comuni, anche tra le famiglie, è che il lavoro finisca con l’uscita dalla comunità. Ma chi ha affrontato una dipendenza lo sa bene: il vero percorso comincia proprio lì. Fuori non ci sono le regole, i ritmi, i contenimenti protettivi della vita comunitaria. Fuori c’è la libertà, ma anche la solitudine. E il rischio concreto della ricaduta.
“La dipendenza è una malattia cronica e recidivante,” ricorda Marco Ameglio. “Anche dopo dieci o vent’anni, può bastare una serata, una frase, un bicchiere per far cadere tutto. Per questo abbiamo creato i gruppi post-comunitari: perché chi esce non resti solo.”
Questi gruppi – attivi anche online – sono un’estensione del lavoro fatto in comunità. Sono spazi sicuri, con regole chiare, dove le persone possono continuare a confrontarsi, a raccontarsi, a ricevere supporto. La partecipazione è riservata a chi ha terminato il percorso e accetta di mantenere la sobrietà: “Nessun uso di sostanze, nessun abuso di farmaci, niente ambiguità. È un gruppo che tiene, ma solo se è trasparente.”
Molti partecipanti restano in contatto per anni. “Ci sono persone che vengono da otto, nove anni. È diventato un punto di riferimento nella loro vita. Un luogo dove ricordarsi chi sono, dove hanno cominciato, e perché non vogliono tornare indietro.”
Questa continuità ha un valore inestimabile. Non solo per evitare la ricaduta, ma per consolidare nel tempo un’identità nuova, sobria, autonoma, capace di affrontare la vita reale con le sue emozioni, i suoi dolori, le sue sfide. I gruppi post-comunitari sono, a tutti gli effetti, una forma di prevenzione secondaria: tengono viva la consapevolezza e riducono drasticamente il rischio di perdere quanto conquistato con tanta fatica.
E non è solo un supporto individuale. È anche un modo per creare comunità tra pari, per alimentare il senso di appartenenza, per dare a chi ha attraversato l’inferno la possibilità di essere esempio, guida, voce per chi sta ancora cercando la strada.
Marco lo dice chiaramente: “Non è un gruppo qualsiasi. Non è un’alternativa ad Alcolisti o Narcotici Anonimi. È una prosecuzione strutturata, che mantiene il rigore del percorso terapeutico. E per molte persone, questo fa la differenza.”
Prevenzione e sostegno continuativo

Prevenire è meglio che curare, si dice. Ma nel caso delle dipendenze, questa affermazione rischia spesso di rimanere uno slogan, se non si traduce in azioni concrete, accessibili e capillari. Per Marco Ameglio, la vera sfida non è solo “salvare” chi è già dentro la spirale, ma raggiungere chi è ancora nel silenzio, nella confusione, nella vergogna.
“C’è troppo poco ascolto. Troppo poco orientamento. Troppa solitudine. Le famiglie arrivano devastate, senza sapere a chi rivolgersi. E a volte bastano 10 minuti al telefono, una voce competente e presente, per cambiare tutto,” racconta Marco.
È per questo che insiste sull’importanza di rafforzare due momenti cruciali nel percorso di cura:
Il prima: intercettare chi è nel buio
Prevenzione non significa solo fare educazione nelle scuole (che resta fondamentale), ma anche offrire spazi di ascolto e orientamento per chi non ha ancora trovato il coraggio di chiedere aiuto.
Sportelli informativi, linee telefoniche, chat, gruppi aperti… Tutti strumenti che possono rappresentare la prima mano tesa per una madre disperata, un padre che non sa cosa fare, un giovane che inizia ad avere dubbi su sé stesso. Spazi dove si possa parlare senza giudizio, capire quali sono le opzioni, ricevere un’indicazione concreta.
Il dopo: non lasciare soli
Uscire da una comunità senza avere un “dopo” strutturato è come essere lasciati in mezzo al mare dopo aver imparato a nuotare in piscina. Per questo i gruppi post-comunitari, i percorsi di reinserimento, i momenti di confronto devono essere pensati come parte integrante del trattamento, non come un optional.
E anche le famiglie devono continuare il loro percorso: “Mai insieme ai pazienti, sempre separati. Ma sempre presenti,” sottolinea Marco. Genitori, partner e fratelli devono imparare a gestire i propri vissuti, i propri automatismi, e continuare a sostenere senza ricadere nei vecchi schemi.
Costruire una rete vera
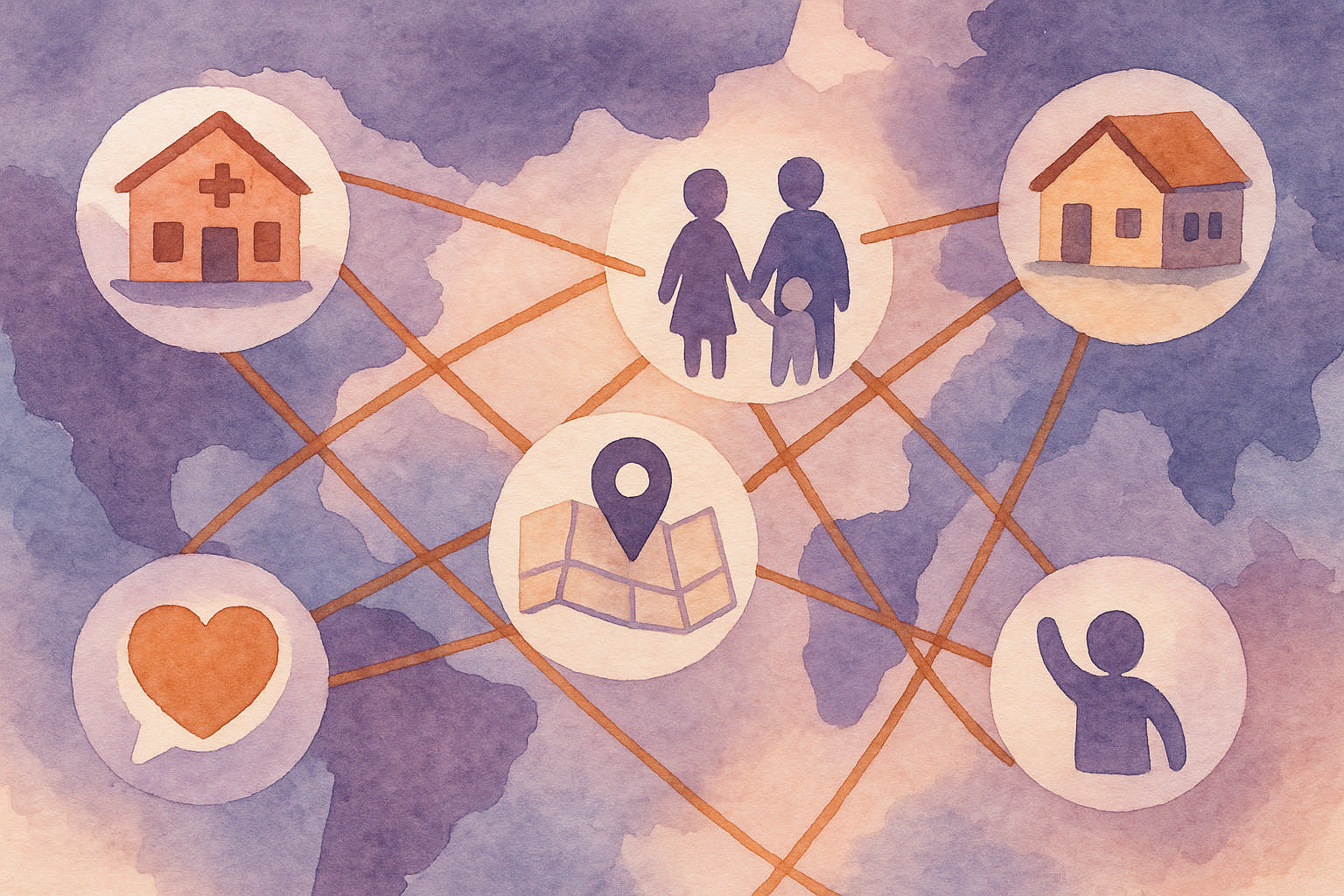
Infine, c’è un’esigenza ancora più ampia: fare rete tra servizi, comunità, fondazioni, territori. Perché solo così si può garantire una presa in carico reale, umana e continuativa. “Non bastano buone intenzioni. Serve coordinamento, formazione, visione. E anche risorse, perché oggi molti servizi sono allo stremo,” denuncia Marco.
In quest’ottica, la Fondazione Laura e Alberto Genovese si impegna a essere un nodo stabile di questa rete, offrendo informazione, ascolto, orientamento e accompagnamento per famiglie e pazienti. Perché la prevenzione non è un evento: è una cultura. E va coltivata ogni giorno, con cura, attenzione e presenza.
Conclusione: Consapevolezza e Speranza

C’è un momento preciso, in ogni percorso di guarigione, che segna una svolta. Non è la fine del programma terapeutico, né l’uscita dalla comunità. È il momento in cui una persona riconosce davvero di essere malata, e accetta di curarsi. Una consapevolezza che non si impone, non si forza, ma si costruisce – giorno dopo giorno – nel silenzio, nell’ascolto, nella relazione.
Marco Ameglio lo sa bene: “Quando un paziente raggiunge quella consapevolezza, nasce la gratitudine. Per chi l’ha fermato. Per chi ha tenuto il scacco. Per chi non ha mollato, anche quando sembrava inutile.” E quella gratitudine, spesso, arriva anche nei confronti dei familiari che hanno avuto il coraggio di prendere decisioni difficili. Di amare con fermezza. Di accompagnare senza sostituirsi.
La dipendenza è una malattia cronica e recidiva. Non se ne esce con la forza di volontà. Non basta voler bene per salvare qualcuno. Serve tempo, serve struttura, serve una rete. Ma soprattutto, serve smettere di avere vergogna. “Come per il cancro, come per la depressione, anche la dipendenza va riconosciuta come una malattia. Non come un fallimento personale,” sottolinea Marco.
È con questo spirito che la Fondazione Laura e Alberto Genovese si impegna ogni giorno a informare, formare e sostenere. A raccontare storie vere, a offrire strumenti pratici, a costruire percorsi concreti. Perché nessuna famiglia deve più sentirsi sola. Perché ogni crisi può diventare l’inizio di un cambiamento.
E perché, anche quando tutto sembra perduto, la speranza – se accompagnata dalla consapevolezza – può aprire nuove strade.


